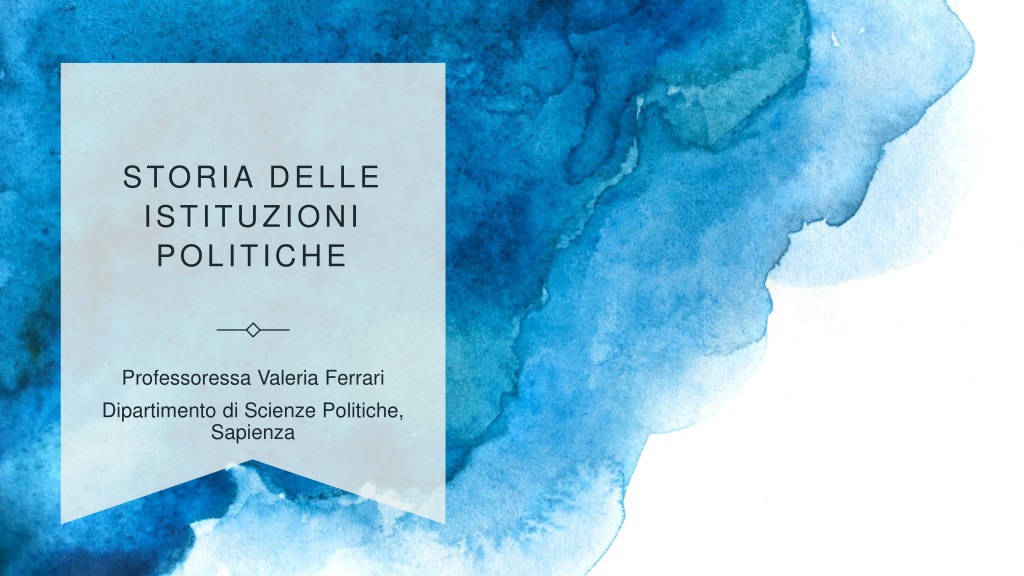
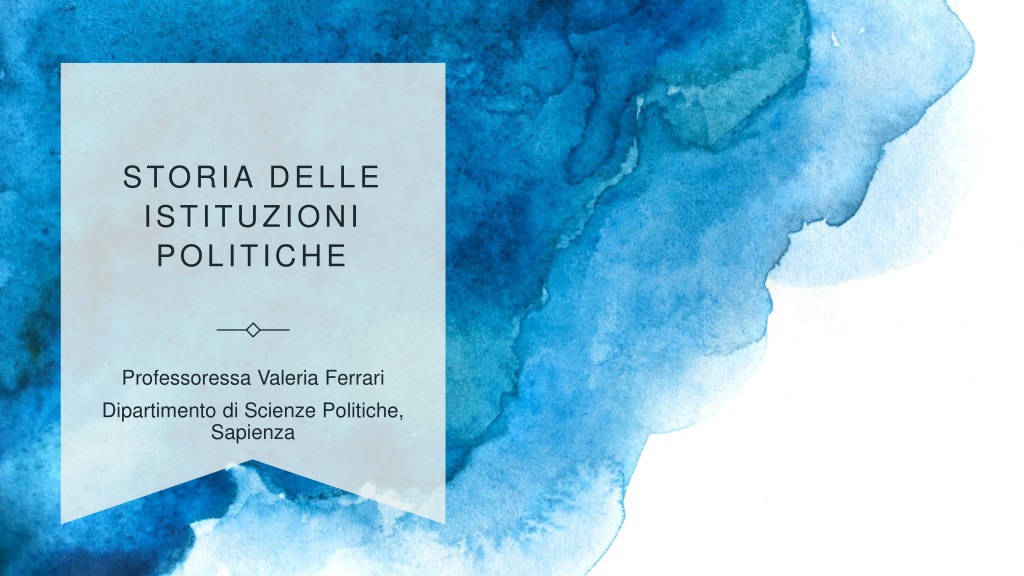
0 likes | 11 Views
Absolutism in France evolved from sporadic royal legislative power in the Middle Ages to direct expression of royal will by the XVI century. The monarch gained authority over legislation, including interpretation and modification of laws. Key institutions like the Councils and royal officials played pivotal roles in administering the realm. The concept of venal offices emerged, perpetuating the influence of nobility. Absolutism in France underwent changes over time, culminating in the reign of Louis XVI.

E N D
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE Professoressa Valeria Ferrari Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza
IL PROTOTIPO DELL’ASSOLUTISMO: LA FRANCIA D’ANCIEN RÉGIME
All’inizio del XVI sec. in Francia l’assolutismo si manifesta inizialmente come un’evoluzione dell’esercizio della funzione legislativa. La nascita dell’assolutismo Nel Medioevo, infatti, l’esercizio di tale potestà da parte del monarca era un evento sporadico ed eccezionale (ciò, in ragione della natura prevalentemente consuetudinaria del diritto). Al contrario, ora diviene espressione diretta della volontà regia.
«Si veut le roi, si veut la loi» (così vuole il sovrano, così vuole la legge) La prima autoritaria e formale assunzione regia del potere legislativo risale a una dichiarazione di Francesco I, datata 1523, in cui egli afferma esplicitamente che «spetta solo al sovrano la potestà̀ di fare ordinamenti, statuti, editti quali appaiono convenienti al bene del re e del regno». In altre parole, la legge promana dal re ed egli, pertanto, è al di sopra della legge stessa. In tale potere legislativo era compresa anche la possibilità di interpretare e modificare le leggi.
A partire da fine XV sec. – inizio XVI sec. le leggi promanate dai sovrani francesi assunsero due forme differenti: 1) Le più note e comuni ordinanze (ordonnances) prevedevano ordini perentori diretti perlopiù a comandi militari, navali e uffici amministrativi. Esse erano prive del nome del destinatario, di premesse esplicative e di sigillo reale. 2) Le lettere patenti, invece, erano forme particolari di ordinanze (ossia «aperte») che recavano sia il nome del destinatario (funzionari o uffici), che il sigillo reale, la firma del sovrano e la controfirma di un segretario o di un ministro.
IL RE E I SUOI CONSIGLI - Il Consiglio Privato (o Consiglio del Re) Gli strumenti dell’assolutismo esistente già nel Medioevo, assisteva i sovrani nelle attività amministrative, finanziare e giudiziarie; - Il Consiglio degli affari nato nel XVI sec. sotto Francesco I, era composto da un gruppo ristretto del Consiglio a cui venivano affidate le questioni politiche più importanti.
- Consiglio degli affari e dei dispacci (già Consiglio Privato) A partire dal secolo successivo, sotto la guida di Richelieu, questi due Consigli del re divennero rispettivamente: - Consiglio segreto degli affari (già Consiglio degli affari, più ristretto e politicamente più rilevante)
- Il Consiglio degli affari e dei dispacci perse progressivamente d’importanza e tornò a chiamarsi Consiglio Privato.la sua funzione si limitava al disbrigo della sola corrispondenza amministrativa; Infine, sotto il regno di Luigi XVI - Il Consiglio segreto degli affari divenne, al contrario, sempre più rilevante e prese il nome di Consiglio di Stato in alto. - Infine, vide la luce un nuovo Consiglio: il Consiglio reale delle finanze.
GLI UFFICIALI E I COMMISSARI Grandi Ufficiali della Corona alti dignitari vicini al re che avevano il compito di manifestare al sovrano i loro personali punti di vista. Fra questi vi erano: Gli strumenti dell’assolutismo il Siniscalco, che sovrintendeva all’organizzazione della vita materiale del re; il Camerario, che aveva compiti di carattere finanziario; il Cancelliere, che era una sorta di primo ministro a capo dell’amministrazione civile e giudiziaria del regno.
Perché perse la qualifica di «guardasigilli»; ma, soprattutto, perché i sovrani francesi non tolleravano più la loro tutela. Tuttavia, a partire dal ‘500, la figura del Cancelliere cominciò a perdere di importanza per due ragioni: Dunque cominciarono ad affiancarli con altri funzionari, nominati dal re, detti Segretari. Già verso la metà del ‘500 presero il nome di Segretari di Stato e divennero sempre più rilevanti.
Vi erano, infine, figure di rango inferiore Gli ufficiali Era la categoria più numerosa e comprendeva sia cariche militari che civili (soprattutto nei settori della giustizia e delle finanze). Poiché la loro nomina non aveva limiti di durata, queste cariche divennero via via ereditarie, dando così vita al cosiddetto fenomeno della venalità delle cariche. I commissari Essi erano nominati dal re «a tempo determinato» per lo svolgimento di una specifica mansione e offrivano al sovrano garanzia di lealtà maggiore degli Ufficiali che, contrariamente, erano inamovibili.
La venalità delle cariche • Gli ufficiali erano nominati dal re e la nomina avveniva senza limiti di durata. A causa di ciò, con il passare del tempo, gli ufficiali divengono veri e propri proprietari del loro ufficio, che quindi può essere venduto o ereditato grazie alla possibilità di dimettersi designando un successore (resignatio in favorem). • Il fenomeno della venalità delle cariche porta allo scontro l’antica nobiltà di spada (noblesse d’épée) di origine feudale e la nuova classe sociale della nobiltà di toga (noblesse de robe), formata da individui di origine borghese che, attraverso la compravendita degli uffici, si inserirono nell’apparato burocratico statale, arrivando a poco a poco a sostituire quasi del tutto l’antica nobiltà di spada nei più importanti settori dell’amministrazione pubblica. • La venalità delle cariche iniziò a diffondersi nel XV secolo, ma raggiunse proporzioni considerevoli nel ’600 fino a diventare un pericolo per la Corona, dal momento che gli ufficiali non potevano in alcun modo essere rimossi dal sovrano.
Gli Intendenti A partire dal XVII secolo il monarca cominciò ad avvalersi di una categoria particolare di Commissari, i cosiddetti Intendenti (la denominazione ufficiale era «Intendenti di giustizia, polizia e finanza»). Essi erano scelti fra i Maîtres de requêtes de l’hôtel du Roi, una categoria di funzionari particolarmente esperti e versati nelle materie giuridiche. Gli Intendenti restavano in carica per circa 20 o 30 anni, erano indipendenti da ogni altra autorità locale e rispondevano dei loro atti solo verso il re e i suoi Consigli. I loro compiti erano molto vasti e comprendevano i settori: • finanziario (avevano l’incarico di provvedere alla ripartizione dei tributi), • giudiziario (sovrintendevano il corso della giustizia ordinaria), • di“polizia”(garantivano e vigilavano sull’ordine pubblico).
Il parlamento I Parlamenti francesi non sono istituzioni rappresentative, bensì collegi di alti magistrati e I freni all’esercizio del potere assoluto costituiscono uno dei tratti più caratteristici della monarchia francese d’ancien régime. Le assemblee rappresentative o Gli Stati Generali (Etats Généraux) o Gli Stati Provinciali
Nato nel 1307, sotto il regno di Filippo il Bello, il Parlamento (Parlement) era l’organo giudiziario per eccellenza e aveva il privilegio di rendere giustizia, nonché emanare decreti (arrêts) e sentenze in suo proprio nome. Il Parlement A partire dal 1443 dovettero aggiungersi altri Parlamenti per integrare l’attività del Parlamento di Parigi (che godeva del prestigioso appellativo di «Corte Sovrana»), ma anche per sminuirne la crescente autorità. Il Parlamento era composto da giudici chiamati consiglieri (i quali erano ufficiali e, pertanto, inamovibili), dai dodici Pari del regno (ossia i titolari delle dodici maggiori signorie feudali), dalla gens du roi, formata dal procuratore del re e da un numero variabile di avvocati del re, e, soprattutto, dai maîtres de requêtes.
La struttura del Parlamento si componeva di varie Camere, corrispondenti alle diverse fasi processuali. 1. La più importante era la cosiddetta Grande Chambre, investita dei giudizi e delle decisioni di maggior rilievo,composta da 34 consiglieri anziani; 2. La sezione penale chiamata Tournelle (poiché ne facevano parte, a rotazione, i membri delle altre sezioni del Parlamento); 3. la Camera delle Inchieste (Chambre des Enquêtes) nella quale avveniva la fase istruttoria; 4. la Camera delle Richieste (Chambre des Requêtes); 5. infine, una camera funzionante nei periodi di vacanza del Parlamento detta appunto Chambre de Vacation. A capo di ogni camera vi era un Presidente e a capo dell’intero Parlamento vi era un Primo Presidente, di nomina regia,che esercitava la direzione dell’intero complesso.
Le funzioni del Parlamento o La competenza giurisdizionale del Parlamento era ampia e comprendeva ogni controversia civile,penale o amministrativa non riservata direttamente al sovrano e al suo Consiglio. o Emanava regolamenti giudiziari obbligatori per giudici e professionisti legali e dava ordini in materia di rapporti di lavoro, polizia e commercio. o Ma l’importanza storica e politica del Parlamento parigino è strettamente connessa ad un’altra sua importante funzione, vale a dire la registrazione delle ordinanze regie. Pertanto, quando i membri del Parlamento nutrivano dubbi circa il contenuto di un’ordinanza, indirizzavano segretamente al sovrano delle remontrances (rimostranze), che avevano la funzione di invitarlo a revocare il provvedimento in questione. Tuttavia, i sovrani non accettavano quasi mai tali interferenze e rispedivano al mittente le cosiddette lettres de jussion (lettere d’ingiunzione), che però normalmente non bastavano a piegare il Parlamento, il quale procedeva con vives et itératives remontrances (rimostranze reiterate). L’unico rimedio contro l’opposizione del Parlamento era, quindi, il lit de justice («letto di giustizia»), che rendeva obbligatoria la registrazione dell’ordinanza rendendola effettiva ipso facto.
Uno dei momenti principali di conflitto nei rapporti fra Stato francese e Santa Sede fu, senza dubbio, la Prammatica Sanzione di Bourges (emanata da Carlo VII il 7 luglio 1438; registrata nel 1439). I RAPPORTI TRA CORONA E PARLAMENTO in merito alla politica ecclesiastica Essa - dichiarava l’illegittimità delle richieste della Santa Sede di tassare il clero francese; - stabiliva che la nomina dei titolari dei benefici ecclesiastici dovesse spettare prevalentemente al sovrano francese. Nonostante le proteste del Papa, fu soltanto sotto il regno di Francesco I che le due parti trovarono un accordo tramite il Concordato di Bologna del 1516, stipulato con il papa Leone X. Essi sono utili a mostrare l’importanza del Parlamento quale freno all’assolutismo regio.
Con il Concordato di Bologna (1516) fra Francesco I e papa Leone X Il papa ottiene: • La possibilità di percepire dei tributi annuali da parte dei nuovi investiti (le cosiddette annate); • La possibilità di rifiutare i candidati proposti dal re fino a 3 volte. Il sovrano ottiene: • Il riconoscimento della sua autorità; • Il versamento, da parte del clero francese, di un contributo finanziario di natura eccezionale chiamato decima. Fu il primo passo verso l’introduzione di una forma di tassazione del clero, poi effettivamente introdotta con il contratto di Poissy nel 1561. Grazie a questo contratto il sovrano poteva rivolgersi all’Assemblea del Clero di Francia per chiedere un aiuto finanziario che, a partire dal 1595, acquisì periodicità decennale.
Fin dall’alto Medioevo i sovrani francesi percepivano i frutti dei benefici vacanti:era la cosiddetta régale temporale. Tuttavia, all’inizio del Seicento, essi cominciarono ad attuare anche una sorta di régale spirituale, cioè la nomina, a titolo provvisorio, dei reggenti degli stessi benefici,fino alla nomina dei nuovi titolari. Un’altra importantissima controversia fra Stato francese e Chiesa di Roma ebbe origine con la disputa delle regalie Il clero resistette a lungo a tale novità, fino a quando, nel 1673, Luigi XIV decretò tramite lettere patenti la régale spirituale come norma di applicazione generale. Ma poiché la questione aveva generato anche delle proteste da parte della Santa Sede (nel 1678 diventa papa Innocenzo XI), che riteneva che tale prassi violasse il Concordato del 1516, Luigi XIV convocò un’Assemblea (1681-82) straordinaria del Clero di Francia e fece approvare un testo di risoluzione che confermava, in sostanza, quanto già̀ disposto in precedenza dalle sue lettere patenti. regalia (o, in francese, régale) significa «prerogativa regia»
La disputa delle regalie portò alla redazione dei «Quattro Articoli» della Chiesa Gallicana Successivamente alla convocazione dell’Assemblea del Clero francese da parte di Luigi XIV, venne istituita al suo interno una commissione che lavorava sul problema della libertà della Chiesa francese. 1) indipendenza del clero di Francia dal potere secolare; 2) autorità degli antichi concili; 3) superiorità su ogni altro potere ecclesiastico del concilio universale; Alle proteste di papa Innocenzo XI contro l’acquiescenza dell’Assemblea, la commissione rispose con una dichiarazione del 1682 (redatta principalmente da Bossuet) che sanciva formalmente i 4 articoli principi della Chiesa gallicana: 4) necessità dell’approvazione della Chiesa per rendere infallibili le decisioni pontificie. Il 20 marzo 1682 il re con un editto confermò i quattro articoli come dottrina ufficiale del regno da insegnarsi in tutte le facoltà di teologia e di diritto canonico.
La politica religiosa del Re Sole fu caratterizzata: • dalla difesa del Gallicanesimo contro la Chiesa di Roma; • dalla lotta contro le minoranze religiose. Luigi XIV perseguitò, infatti, tanto i giansenisti che gli ugonotti: Il giansenismo fu il principale movimento di dissidenza cattolica del ’600 e del ’700 e sosteneva che la grazia fosse un dono divino concesso solo ai predestinati. A tale visione si accompagnava una religiosità austera e rigorosa. Altrettanto intransigente fu l’atteggiamento del sovrano nei confronti degli ugonotti, che già assediati in passato da Richelieu, nel 1685 furono privati da Luigi XIV anche della libertà di culto in seguito alla revoca dell’editto di Nantes. La più importante comunità di giansenisti si riuniva nel convento di Port-Royal, contro il quale Luigi XIV intervenne a più riprese fino alla sua definitiva soppressione nel 1709.
L’occasione di maggiore scontro politico tra Corona e Parlamento fu quello della cosiddetta Fronda parlamentare. Essa fu un movimento di rivolta e opposizione del Parlamento di Parigi contro il cardinale Mazzarino (e conseguentemente contro la regina Anna d'Austria, reggente in nome del figlio Luigi XIV), che ebbe inizio nel 1648. La Fronda Parlamentare del 1648 Protagonista di questa rivolta fu la nobiltà parigina, tanto di toga (nobiltà di nuova acquisizione) che di spada (nobiltà storica). Essa infatti non tollerava la tendenza assolutista dei re di Francia, particolare il governo instaurato dal cardinale Mazzarino durante il periodo di reggenza diAnna d'Austria. e in
Gli eventi • Nel 1648 il Paese usciva dalla guerra dei Trent’Anni (1618-1648), che pur conclusasi favorevolmente per la Francia, aveva prodotto notevoli danni sia in termini economici che di perdite umane. • Inoltre, qualche anno prima erano morti sia il sovrano Luigi XIII (1643) che il cardinale Richelieu (1642), a cui erano succeduti rispettivamente il futuro Luigi XIV,ancora bambino,e il cardinale Giulio Mazzarino.Ma poiché il sovrano aveva solo 5 anni,la reggenza fu assunta da sua madreAnna d’Austria. • Il motivo scatenante della rivolta parlamentare fu essenzialmente di natura fiscale: il Mazzarino, primo ministro Francia, nella perenne ricerca di fondi per finanziare l’intervento militare francese durante la guerra, promosse l’istituzione di nuove tasse che andavano a colpire gli interessi tanto della nobiltà terriera e che degli alti funzionari dello Stato, tra cui molti membri del Parlamento di Parigi,che per tale ragione si fece principale promotore del conflitto. • Tra il 1648 e il 1650, Mazzarino cercò di piegare il Parlamento con l’uso della forza in tre distinte occasioni – nel corso delle quali fece arrestare alcuni membri del Parlamento – senza tuttavia riuscire a sconfiggere l’opposizione parlamentare. Per tale ragione, nel 1650 esplose la seconda fase della Fronda, la cosiddetta Fronda dei principi (o Fronda Nobiliare), capeggiata dal principe di Condé. • Tale situazione di stallo proseguì fino al 1651, quando venne dichiarata la maggiore età del nuovo sovrano Luigi XIV.
• nel 1653 pronuncia in lit de justice un editto in cui vieta al Parlamento di occuparsi in alcun modo degli affari di Stato o di questioni finanziarie; • nel 1661, dopo la morte di Mazzarino, assume la pienezza dei poteri dichiarando di voler governare in prima persona senza l’aiuto di un primo ministro; • nel 1668 fa cancellare i decreti con rilevanza politica emessi dal Parlamento nel periodo della Fronda; • infine, a coronamento del suo progetto di ridimensionamento dell’autorità del Parlement, nel 1673 fa approvare con un lit de justice un’ordinanza che decapita la funzione politica del Parlamento conquistata nel corso dei secoli: tale ordinanza, infatti, impedisce ai parlamentari di presentare le rimostranze prima della registrazione delle ordinanze,riconoscendo la legittimità di esse soltanto a registrazione avvenuta.
I rapporti con il Parlamento durante la reggenza di Filippo d I rapporti con il Parlamento durante la reggenza di Filippo d’ ’Orléans e il regno di Luigi XV il regno di Luigi XV Orléans e • Alla morte del Re Sole (avvenuta il 1 settembre 1715), Filippo d’Orléans si oppose alle ultime volontà di Luigi XIV, che designava quale reggente dell’unico erede legittimo, ma ancora minorenne, un altro dei suoi figli naturali, Luigi Augusto. In quanto ascendente più prossimo dell’erede al trono, Filippo chiese però al Parlamento di Parigi di invalidare il testamento del Re Sole promettendo in cambio il ripristino del potere di rimostranza. • Fu Fu cosi così che Luigi Luigi XV XV ( (1715 che ebbe ebbe inizio 1715- -1774 1774) ). inizio la la reggenza reggenza di di Filippo Filippo II II d d’ ’Orléans Orléans ( (1715 1715- -1723 1723), ), zio zio del del futuro futuro sovrano sovrano • Durante i primi anni di tale reggenza, l’aristocrazia riuscì a imporre il sistema della polisinodia (1715-1718), vale a dire un regime caratterizzato dalla presenza di 7 nuovi Consigli formati da un numero variabile di membri scelti sia fra la nobiltà di toga sia fra quella di spada. Si trattò di un tentativo, da parte dell’antica aristocrazia, di riconquistare il potere politico perso con l’affermazione dell’assolutismo. polisinodia
Lettres Lettres historiques historiques sur sur les les fonctions fonctions essentielles essentielles du du Parlement Parlement ( (1753 1753) ) Pubblicando in forma anonima le Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, redatte in realtà dal consigliere Adrien Lepaige, nel 1753 il Parlamento giunse a elaborare una vera e propria teoria dei suoi diritti politici: 1. La rivendicazione della piena libertà di verifica delle leggi del sovrano; 2. L’idea che le leggi dovessero considerarsi perfette solo se recanti la formula di approvazione da parte del Parlamento; 3. La cosiddetta “teoria delle classi”, in virtù della quale tutti i Parlamenti del regno altro non erano che “classi”, ossia parti, solidali fra loro, di un Parlamento unico e indivisibile. Il Parlamento rivendicava, dunque, per sé un ruolo politico di primo piano in quanto unico argine all’assolutismo monarchico. Nella seconda metà del Settecento, inoltre, si affermò il principio dell’illegalità delle sanzioni nei riguardi dei parlamentari, i quali, in quanto inamovibili dalla loro carica, erano da considerarsi inviolabili.
• L’atteggiamento di Luigi XV nei confronti del Parlamento fu sempre ambivalente e contraddittorio, anche a causa delle contrapposte influenze che condizionavano la sua linea politica: da un lato vicine alla Chiesa, dall’altro più laiche e filo-illuministe. • Gli ultimi anni di regno di Luigi XV videro accentuarsi i contrasti fra Corona e Parlamento:nel 1766,in un lit de justice, il sovrano condannò apertamente le pretese del Parlamento di arrogarsi funzioni rappresentative. • Pochi anni più tardi, nel 1771, con quello che venne definito un vero e proprio “colpo di Stato”, il cancelliere Maupeou propose di abolire la venalità delle cariche introducendo nuovi magistrati nominati dal re e di sciogliere il Parlamento di Parigi, istituendo in sua vece 6 Consigli superiori di appello i cui membri potevano essere revocati dal re. • La riforma andò in porto nonostante le proteste della nobiltà di toga, ma in seguito all’improvvisa morte del sovrano, nel 1774, il Parlamento venne ripristinato in tutte le sue tradizionali funzioni.
Stati Generali (Etats Généraux) è l’espressione con cui veniva chiamata l’assemblea rappresentativa della Francia d’ancien régime. Le assemblee rappresentative Nati nel XIII sec., assunsero la loro fisionomia definitiva nel 1302 sotto il regno di Filippo il Bello, quando si composero per la prima volta di • Nobiltà • Clero • Terzo Stato (i rappresentati della città)
Un’altra assemblea rappresentativa della Francia d’ancien régime era costituita dai cosiddetti Stati provinciali il cui ruolo istituzionale consisteva nella ripartizione dei tributi fra i membri della comunità, ma de facto, la loro importanza storica consistette soprattutto nella custodia delle consuetudini locali.
Le funzioni degli Stati Generali Le funzioni degli Stati Generali Originariamente, nell’arco del XIII secolo, la funzione degli Stati Generali era puramente di parata, ossia di prendere atto delle decisioni del sovrano. Nel corso del secolo successivo il ruolo di tale assemblea divenne, invece, più propriamente consultivo. Con la convocazione del 1484, gli Stati cessano di essere un’assemblea consultiva per divenire un vero e proprio organo deliberativo. Nonostante ciò, la presenza degli Stati Generali nell’ancien régime fu del tutto episodica e di scarso rilievo istituzionale, soprattutto perché il modello assolutistico ne fece abilmente a meno.
Le convocazioni degli Stati Generali Le convocazioni degli Stati Generali o 1355 1355- -1358 di Proprio in questa fase, l’assemblea avanzò la richiesta di due importanti riconoscimenti: 1358: : Durante la Guerra dei Cento Anni (1337-1453), a causa della prigionia del re Giovanni II Valois, gli Stati Generali furono furono convocati convocati in in modo modo quasi quasi permanente permanente. 1 1) il diritto alla convocazione periodica ) il diritto alla convocazione periodica Non venne accolta Venne accolta e divenne la funzione più rilevante degli Stati Generali. 2 2) la partecipazione diretta ai tributi ) la partecipazione diretta ai tributi o Nei decenni successivi, però, una volta ritornata alla normalità la situazione interna della Francia, gli Stati non vennero convocati fino al 1484.
o 1484 1484: : Tale convocazione, a Tours, è ritenuta dagli studiosi il momento in cui l’Assemblea matura la consapevolezza del proprio ruolo rappresentativo e diventa un delibera deliberativo tivo. . un vero vero e e proprio proprio organo organo In questa occasione, infatti, gli Stati ribadirono le richieste avanzate in passato, accentuando soprattutto quella sulla partecipazione all’organizzazione amministrativa dello Stato. Tali richieste vennero accolte, de jure, dai reggenti Anna di Beaujeu (sorella del futuro re Carlo VIII, ancora minorenne) e suo marito Pietro II di Borbone. L’elezione divenne la modalità ordinaria di reclutamento dei rappresentanti dei tre Stati, che venivano eletti con mandato mandato imperativo imperativo. .
o Nel periodo di maggiore rilevanza politica degli Stati Generali, cioè̀ dal 1484 al 1614, si ebbero in tutto 8 riunioni. o Un periodo particolarmente rilevante fu quello delle guerre di religione, durante il quale, approfittando della condizione di evidente debolezza della monarchia, gli Stati cercarono di ottenere definitivo riconoscimento del loro ruolo rappresentativo. Alla vigilia delle guerre di religione l’assemblea fu convocata due volte:nel 1560 a Orléans e nel 1561 a Pontoise;successivamente vi fu una convocazione a Blois nel 1576 in cui ci fu spaccatura tra i rappresentanti degli Stati per il voto sulla taglia; infine, ce ne fu un’ultima a Parigi nel 1593 sotto il regno di Enrico IV. o Dopo questo periodo,vi fu un’ultima convocazione nel 1614,durante la reggenza di Maria de’Medici. o Con la definitiva affermazione dell’assolutismo in Francia,non vi fu più alcuna convocazione fino al 1789.
Approfondimento sulle Guerre di religione Le proteste della popolazione contro la taglia fu una delle cause principali delle guerre di religione. La taglia (taille), infatti, era una tassa regia sulle persone e sui beni che nel corso del ‘500 aumentò in maniera considerevole. I continui aumenti delle imposte e la contemporanea crisi del commercio determinarono la diffusione del calvinismo che, propugnando l’uguaglianza politica e sociale, si opponeva all’assolutismo monarchico. Nacque pertanto un vero e proprio partito rivoluzionario contro cui si oppose la famiglia dei Guisa, fedele al cattolicesimo. Ne derivò una cruenta guerra civile che culminò, il 24 agosto 1572 nella strage della notte di S.Bartolomeo.
Dopo la strage della notte di S. Bartolomeo la fazione protestante si era riorganizzata sotto la guida di Enrico di Borbone;quella cattolica aveva invece costituito una Lega Santa guidata da Enrico di Guisa. La guerra si concluse nel 1589 con l’ascesa al trono di Enrico di Borbone con il nome di Enrico IV, il quale abiurò il calvinismo e si convertì al cattolicesimo. Nello stesso anno della pace di Vervins tra Francia e Spagna,Enrico IV concesse ai protestanti l’editto di Nantes (1598), con cui gli ugonotti si videro riconosciuti gli stessi diritti politici dei cattolici, la concessione di 100 piazzeforti nel paese e la piena libertà di culto.